Pubblichiamo qui di seguito le prime venti pagine di Dante e la selva oscura, di Gianni Vacchelli:
Questo libro di Gianni Vacchelli non intende ‘rimediare’ all’archiviazione della presenza di Dante, non cerca di portare ragioni per riconoscerne l’ ‘attualità’. In questo senso apre piuttosto una via inedita tra la ricezione tradizionale e le letture attualizzanti. Il libro offre tutt’altra prospettiva perché vale per ricondurci alla realtà. Non lo dico in quanto si tratti di un esercizio di ‘realismo’, che di solito serve solo a spegnere l’immaginazione, riducendo l’orizzonte davanti a noi e giustificando l’inaccettabile. Lo dico invece per sottolineare che questo libro richiama al senso della realtà nella misura in cui alimenta la capacità di sperare. La speranza autentica è non solo una forma radicale di intelligenza, in grado di cogliere il bene latente che molti non riescono a vedere, ma è anche una forma di azione, dato che sperare davvero è trovare la libertà di agire nella direzione opposta rispetto a quella tipica di ciò che opprime.
La speranza di cui si parla qui è quella di una liberante trasformazione interiore e politica, personale e sociale. Proprio perché è poeta e pensatore della verità della vita, Dante è testimone della redenzione vissuta come trasformazione liberatrice. In particolare il testo di Vacchelli è esercizio di speranza perché contribuisce a quel recupero di realtà che ci è indispensabile in una stagione storica in cui, come osservava Elsa Morante nel 1965, il mondo corre alla sua disintegrazione come se fosse il proprio bene supremo. Più smarriscono il contatto con la consistenza e il senso delle presenze date nella vita, più gli esseri umani rimangono sviati, scissi, incoscienti. Da parte sua Martin Buber ricorda come la malvagità sia frutto non di una deliberata e consapevole scelta del male, né di una natura umana corrotta, ma dell’adesione all’irrealtà e della tentazione di sovranità fatta balenare dalla vertigine della pura possibilità, illimitata e senza criteri di senso. Quando accade questo, le persone non vedono più se stesse e gli altri, le istituzioni impazziscono, il mondo diventa preda di processi degenerativi.
Ci si smarrisce nella selva oscura, come spiega nitidamente Vacchelli nei primi tre saggi del volume. In queste pagine egli mostra, con efficace persuasività, quanto l’opera di Dante sia una chiave d’accesso per imparare a vedere e a vedersi. La sua poesia non aggiunge bellezza alle cose, non decora il mondo, non si limita a cantare la vita e l’oltremorte. Essa è esperienza della realtà nelle sue contraddizioni e nei suoi molteplici gradi di profondità. Invita chiunque la legga e l’ascolti a inoltrarsi lungo un itinerario che arriva sino al cuore del reale: si comprende sperimentando, ci si orienta man mano che il cammino procede, si vive il dilatarsi della coscienza così da poter riconoscere ciò che è effettivamente presente, sensato, attendibile. Con precisione Vacchelli afferma: «Dante ancora oggi non anticipa, non precorre i tempi. Ma ne schiude uno del tutto diverso. Vivente. Vitale. Una vita nuova che non vediamo più». Se pensiamo a quanto estranea e irrazionale possa sembrare la realtà a chi è ormai assuefatto all’irrealtà, cominciamo a capire meglio che cosa significhi in ultima istanza il fatto che la Commedia fu scritta da Dante nella condizione dell’esilio.
Il viaggio che porta al recupero della realtà, inaspettatamente scoperta come comunione tra gli esseri che ne partecipano, impegna chi lo effettua su molti versanti. Di qui sia il carattere onnilaterale della lezione di Dante – visto che riguarda l’interiorità e l’azione, il rapporto con gli altri e con sé, con Dio e con il mondo –, sia la molteplicità delle chiavi di interpretazione della Commedia – giacché per ogni passo avanti nella consapevolezza del senso del reale maturano prospettive diverse. Così viene in luce l’articolazione plurale strutturalmente costitutiva dell’opera dantesca. Perciò le grandi correnti del pensiero e della fede operanti nel mondo di Dante vengono studiate da Vacchelli secondo la loro legittima polivocità: i cristianesimi, i paganesimi, le culture.
Tra gli approfondimenti che qui vengono proposti, vorrei richiamare anzitutto la radicalità della coscienza storico‑epocale di Dante stesso. In proposito l’approccio di Vacchelli è particolarmente perspicuo nell’evidenziare come egli seppe riconoscere sul nascere il lunghissimo processo di disarticolazione e di perversione che ha colpito la civiltà europea, denunciando la lupa‑cupiditas‑avaritia. Essa è il simbolo concretissimo dell’economia ridotta a pratica dell’avidità e poi destinata a produrre un giorno, durante quello che sarà il tempo della globalizzazione, la desertificante finanziarizzazione della società mondiale. Ciò indica che Dante effettivamente ha saputo capire la svolta epocale che da allora a oggi ha ridotto la civiltà occidentale ad artefice della mercatizzazione della vita e del mondo. Ha dunque ragione Vacchelli nel sostenere che Dante stesso, con la sua poesia critica e profetica, giudica la nostra storia, offrendoci dei criteri di umanità e di giustizia alla luce dei quali possiamo comprendere quanto sia deformante la mentalità oggi prevalente.
Inoltre, la Commedia accompagna chi la legge e l’ascolta a maturare il senso dell’integrità umana. Un’integrità che prende corpo lì dove si sperimenta la piena adesione alle relazioni vitali. In primo luogo quella con Dio, certo, sentito però non come qualcuno che condanna e atterrisce, bensì come l’Amore che tutto fonda, ordina e guarisce. L’Inferno non è un luogo di eterna punizione, è semmai una situazione di sofferenza già data allorché singoli o intere collettività lacerano il tessuto relazionale della vita e fanno dell’iniquità il loro criterio ispiratore.
Ma la stessa relazione con Dio non si dà nel vuoto, non è privatizzabile, per quanto sia sempre ineludibilmente personale. In essa entrano in gioco due forme di rapporto cruciali. Da un lato c’è il legame tra i vivi e i morti, tutti coinvolti in una comunione più grande della mera esistenza biologica; dall’altro risulta fondamentale la relazione tra l’uomo e la donna. L’alterità nella reciprocità, l’incontro e il desiderio, l’attrazione e l’affidamento entrano in scena restituendo la percezione della forza generativa e universale dell’amore. Una sensibilità simile consente a Dante di evitare lo spiritualismo astratto per rispecchiare invece la forza di comunione universale inscritta nei corpi sessuati. Una forza mai ridotta a libido impersonale perché in essa si esprime ogni volta l’anima, il volto interiore di ciascuno.
Dalla riflessione di Vacchelli si ha modo di considerare la valenza antropologica e metafisica essenziale del pensiero di Dante: egli, infatti, ha saputo superare in profondità gran parte della tradizione occidentale, per la quale l’essere, o la ragione, o il potere sono al centro della realtà. Quest’ultima, invece, proviene dall’Amore. In Dante si dispiegano infatti una metafisica e un’antropologia dell’amore, dove quest’ultimo è molto più che uno stato d’animo, un’emozione, un sentimento o una passione, poiché rivela di essere la forza originaria, creativa e suprema del cosmo e di ogni vicenda biografica. La stessa filosofia è «amoroso uso di sapienza», il che attesta come non si dia conoscenza autentica che non sia esercizio della forza di amare.
L’acutezza di tale consapevolezza metafisica e antropologica proviene dalla stima dantesca per la rilevanza concreta e simbolica dell’incontro tra l’uomo e la donna. Perciò ha ragione Vacchelli nell’affermare: attraversano l’opera di Dante, che è certo insuperabile poeta, ma anche filosofo (e teologo e mistico), intuizioni molto rare e disattese, per lo più, dal pensiero filosofico occidentale. Il grande cammino dantesco nasce dall’incontro dell’altro e dell’altro in quanto donna. Non è un ruotare su se stessi, sul Medesimo, ma una reale apertura al mistero dell’alterità. L’incontro, la relazione sono al centro dell’opera dantesca. E la filosofia e la poesia devono cantare questo incontro di amore e conoscenza che si ha tra uomo e donna, e divenire esse stesse amore e conoscenza.
Tutti questi approfondimenti indicano che il senso di realtà, l’adesione alla vita vera e la maturazione dell’integrità umana crescono insieme, senza scissioni, come ha sostenuto il più volte citato Raimon Panikkar. La Commedia possiede un valore indissolubilmente mistico e politico, riferibile alla ricerca interiore e alla trasformazione della società. Qualunque tentativo di scorporare uno di questi versanti risulterebbe subito miope e illegittimo. Lo si vede nel riferimento, che Vacchelli esplicita con grande finezza, a quelle creature rivelatrici che sono le bambine e i bambini. Sono loro che annunciano la promessa di un mondo liberato. E solo loro hanno la facoltà di manifestare con piena legittimità come la Commedia abbia anche la costituzione di una fiaba; anzi da questo punto di vista si può dire che si tratti di una fiaba di fiabe, perché lungo la narrazione troviamo una grande ricchezza di racconti di quel mondo incantato, per usare l’espressione di Bruno Bettelheim, nel quale tutti abbiamo iniziato a scoprire misteri e meraviglie della vita. Infine vorrei porre in risalto come da questo libro ci sia rispecchiata una verità vitale che da tempo è stata oscurata e suona letteralmente incredibile per la mentalità contemporanea. Alludo al rapporto dell’essere umano con l’eterno. È più che scontato, per quasi tutti, il fatto che ognuno nasce, vive per un certo periodo, muore e si dissolve nel nulla e nell’oblio. Pertanto la temporalità umana sarebbe la mera somma del passato, del presente e del futuro nel loro incessante e spietato trascorrere. Eppure ci sono evidenze della vita che dovrebbero motivarci a cercare una comprensione più profonda del tempo e della nostra stessa umanità.
Per un verso, infatti, sperimentiamo che noi non siamo mai interamente nel luogo dato in qualcuna di queste scansioni temporali. C’è un’eccedenza del nostro essere rispetto al tempo convenzionale e noto. L’arco dell’esistenza è più grande del passato, del presente e del futuro. Per altro verso, ci accorgiamo anche di come, quando muore qualcuno, la presenza e il valore di quella persona superino il fatto della morte, la somma delle cose che ha realizzato e dei suoi anni di vita. Del resto, chiunque s’impegni nella ricerca del senso dell’esistenza sa che possiamo riconoscerlo soltanto quando abbiamo dato adesione a una relazione, a un amore, a un ideale che per noi hanno valore eterno, cioè incondizionato, eccedente la finitezza e la mortalità. Senza tale adesione restiamo ai margini della vita, in una condizione di creature non ancora nate. Invece chi matura questa adesione scopre che l’eterno non è pura quantità illimitata di tempo, ma è tempo definitivo, perfezione del senso, comunione piena, durata di chi e di ciò che ha valore, salvezza.
Ebbene, Vacchelli porta alla luce questo filo conduttore esistenziale dell’eterno che ci riguarda, evitando d’altra parte di rimuovere la fragilità e la mortalità del nostro essere. Dante è maestro nel manifestare come tempo ed eternità siano coimplicati, cosicché, se si prova a separarli, subito si smarrisce il significato dell’uno e dell’altra, nonché della nostra stessa dignità. Ora il termine ‘integrità’ assume finalmente un profilo adeguato e altrettanto accade al termine ‘vita’, che va riconosciuta come la comunità dei viventi non solo in senso spaziale, ma anche in senso temporale aperto, comprendendo le generazioni passate e quelle che verranno. E si comprende forse, da questo punto di vista, come la consegna di sé all’irrealtà, all’avidità, all’iniquità, all’isolamento narcisista o alla disperazione sia il frutto velenoso della credenza nella fine, nel nulla e nell’insensatezza, credenza che inevitabilmente ha l’effetto di chiuderci il cuore.
Facendosi interprete, traduttore e interlocutore di Dante, Vacchelli fa precisamente il contrario di ciò che tende a tale chiusura. Questa sua opera aiuta menti e cuori a riaprirsi, motiva a liberarsi dall’irrealtà, offre ottime ragioni per ricordarsi di coltivare l’integrità umana. E poiché diventare integri, scoprendo la comunione profonda che è il nucleo della realtà, è esperienza che suscita stupore benefico, saggezza e slancio creativo, credo che si debba essere grati a Gianni Vacchelli: il suo lavoro, in dialogo con Dante, ci fa scoprire le meraviglie dell’integrità togliendoci dalla paralisi di chi crede di avere le mani legate e dalla vita non si attende più niente.
Roberto Mancini
Chi veder vuol la salute,
Faccia che li occhi d’esta donna miri,
li occhi di questa donna sono le sue
demonstrazioni, le quali,
dritte ne li occhi de lo ’ntelletto,
innamorano l’anima, liberata da le con[tra]dizioni
(Dante)
La nostra vita non è tanto determinata dalle
influenze subite, ma quanto dal modo in cui
abbiamo imparato a immaginarla
(James Hillman)
Solo con l’utopia e la speranza
si può credere e avere il coraggio,
con tutti i poveri e gli oppressi del mondo,
di invertire la storia, sovvertirla e lanciarla
verso un’altra direzione
(Ignacio Ellacuría)
Il mistico non perde la pace né l’equanimità:
sa però sporcarsi le mani se è necessario.
La fame e la sete di giustizia
sono caratteristiche dello spirito mistico
(Raimon Panikkar)
Anche adesso nel mondo, in luoghi tranquilli,
lontano dai centri sociali consacrati
e dai loro ambienti e controlli,
sono in corso numerose ricerche e scoperte
di profonda rilevanza spirituale:
piccoli gruppi e, più spesso e più tipicamente,
ad uno o due per volta,
penetrano nella foresta in quei punti
che liberamente hanno scelto,
là dove l’oscurità è più fitta e non si scorge
né strada battuta né sentiero
(Joseph Campbell)
Il mito del progresso e della storia va quanto meno ridimensionato e decostruito, quando non rispedito al mittente. Il nuovo ricercato non significa in qualunque caso, con patetica retorica dell’oggi, ‘il più recente’ ma, biblicamente, ‘il definitivo’, che non può essere annientato dal non senso, dal male, dalla morte:6 una definitività di bellezza, di amore, di splendore del vero che, come un filo d’oro, percorre l’intera avventura dantesca. Dante ancora oggi non anticipa, non precorre i tempi. Ma ne schiude uno del tutto diverso. Vivente. Vitale. Una vita nuova che non vediamo più.
I brevi saggi ripercorrono alcune delle più geniali, roventi e troppo corrivamente dimenticate conquiste dantesche: il primato della vita, la mistica trinitaria a disposizione di tutti (non solo dei cristiani), la prospettiva della liberazione di sé, del mondo, della realtà, del divino stesso, la critica nettissima all’accumulo e a un’economia proto‑capitalista intuita come avulsa, disembedded (Polanyi) e ‘dismisurata’, il sogno di un’Europa – ma in verità di una humana civilitas – unita secondo l’ossimoro politico‑ spirituale, la via dell’amore come nuova antropologia, non solo affettiva, ma sociale, politica, la cristofania sofianica e personale di Beatrice, l’iniziazione femminile e regale, i misteri polimorfi e polisemici della selva oscura, soglia dell’anima, l’archetipo del puer‑senex (per cenni) ecc.
Il tutto, dantescamente, in continua colluttazione con il presente dove le derive tecnocratico‑economicistiche, l’accelerazione, l’atomizzazione del tempo (e non solo), il delirio di una ragione calcolante e produttivistica, che si eclissa ma che ancora impazza, dipingono la selva oscura odierna di un nuovo, soffuso e insieme ferreo totalitarismo di specie, sotto tanti aspetti, inedita.
In questo senso dobbiamo ancora diventare contemporanei di Dante, della sua trasformazione profonda, della sua liberazione radicale, della pienezza dell’umano che intravede e ci consegna. Il paradosso è che forse, in tempi terminali e oscuri, Dante può essere letto meglio, più a fondo.
Non si tratta naturalmente di ‘ritornare’ a Dante: sarebbe esito insipiente, reazionario e di fatto insignificante. Talvolta qui diremo piuttosto: ‘ripartire da Dante’, da alcune sue intuizioni al calor bianco. Il passato ha un suo futuro, una sua latenza che, se ripiena di verità, pur se eventualmente sconfitta da una certa storia, attende di essere riattualizzata, in modo nuovo, creativo e senza facili anacronismi. Ernst Bloch lo dice a più riprese e magnificamente: «Ciò che è accaduto è sempre accaduto solo a metà, e la forza che lo fece accadere, che si espresse in esso in maniera insufficiente, continua a operare in noi e getta il suo bagliore anche sui tentativi parziali, ancora futuri che giacciono dietro di noi».
Ma potremmo dire, e forse non solo per assurdo: qualunque riattualizzazione di Dante è impossibile. Inutile. Il mondo di Dante è passato. La sua mistica‑politica svanita. Per sempre. Allora la rievocazione di questo spirito magno, convocato dall’Ade, come lui ci ha insegnato, ci rimanda solo a noi: studiarlo, amarlo, comprenderlo ci fa capire questo mondo in cui siamo, la cui cesura con quello dantesco è probabilmente fatale, irreversibile. Il prima ci mostra quindi che il dopo non va assolutizzato, oggettivato o fatalizzato.
Allora, in qualunque caso, persino Dante crescit cum legente. E soprattutto cresciamo noi, in coscienza, in consapevolezza. E in anima. Perché il punto è anche questo: Dante entra nelle profondità della realtà, nei tempi dell’anima, che non sono riducibili alla cronologia e alla storia. Sono altro: ierostoria, mundus imaginalis, psiche. E noi abbiamo bisogno di «fare anima», di ricordarci che non abbiamo l’anima, ma siamo nell’anima (esse in psiche, ripeteva Jung). Se l’uomo è oggi a una dimensione, o forse a nessuna dimensione, nel nichilismo mercificante neoliberista, in una disumanità del dispositivo impersonale che ci fa disumani, in una banalità non solo più del male, ma della disumanità stessa e del mondo, dobbiamo recuperare tutti i tre mondi: quello fisico, quello intermedio (psichico, immaginale) e quello invisibile, trascendente, intellegibilis. Dante va ed è anche lì. Esiste anche lo spirito. Ma esso appare ancora più enigmatico e lontano, se abbiamo perduto quella terra di mezzo, che ben gli antichi conoscevano, che è istmo e copula tra la manifestazione fisica e l’immanifesto.
Da un punto di vista cronologico e storico sembra esistere solo una unidirezionalità: si torna indietro, cronologicamente, cercando di ricostruire il contesto storico e l’intenzione dell’autore. Oppure si studia come l’opera dantesca abbia una sua straordinaria e pressoché infinita storia degli effetti. Avanti o indietro si è sempre sull’asse della cronologia e della sua logica: passato‑presente‑futuro. Regna la ‘geometria euclidea’. Tuttavia la lettura storico‑critica non è l’unica, anche se non va dismessa.
In ottica simbolica, interiore, ma attenta pure, in modo radicale, alla ricezione, potremmo dire che questo movimento sull’asse cronologico è solo una delle possibili direzioni.
Infatti, ad esempio, possiamo tornare alla Commedia, rileggendola anche arricchiti dalla prospettiva emersa da ciò che è venuto dopo di essa, e quasi portandola, gramscianamente, all’altezza dei nostri tempi, come se il passato diventasse, per così dire, presente, se non futuro, e come se solo adesso potessimo comprenderlo meglio, se non pienamente. Il movimento è paradossale, non euclideo, se visto solo dalla prospettiva cronologica, ma pure rende giustizia all’incremento semantico e simbolico che altri mondi storici, altre e nuove cosmovisioni, altre opere (storia o non storia degli effetti della Commedia, che siano), altri mythoi (intesi come orizzonti di comprensione) hanno generato. Si ricordi sempre il motto di Gregorio Magno, applicato alle Scritture: Scriptura crescit cum legentibus. Così, anche Dante cresce con chi lo legge, dicevamo sopra. Quindi è assolutamente legittimo leggere la Commedia secondo il mythos della storia. Ma ne esistono altri: il mythos dell’Anima e dei suoi archetipi, il mythos simbolico, il mythos della ricezione ecc. Nessuno è esclusivo, ma hanno tutti le loro ragioni, fosse pure gerarchicamente.
Così, per esempio, posso naturalmente vedere come Primo Levi utilizzi in Se questo è un uomo costanti e continui echi danteschi, espliciti e celeberrimi (l’episodio del canto di Ulisse nel lager), e più nascosti e disseminati nel testo. In questo caso seguo sempre la direzione cronologica: sto osservando come un testo antico ne abbia generato, almeno in parte, uno nuovo, e come Levi abbia avuto bisogno dell’Inferno dantesco per dire Auschwitz. «Auschwitz è l’inferno», scrive Levi. Naturalmente evidenzio anche come Levi usi Dante per dire cose che Dante non poteva dire. L’Inferno di Dante non è Auschwitz. E la differenza è, da questo punto di vista, radicale. Irriducibile. Il medioevo non può produrre un olocausto industriale, tecnologico, efficientista e di fatto capitalista.
Eppure, se come uomo che viene dopo Auschwitz (e dopo le due bombe atomiche) rileggo Dante non cancellando la mia memoria, conscia e inconscia, di ciò che è stato, forse, in qualche modo, trovo anche Auschwitz nell’Inferno di Dante. E io, lettore post‑Auschwitz, arricchisco, re‑immagino, ri‑vedo, pure dis‑torco il testo dantesco, portandolo qui, nel presente, facendolo viaggiare nel futuro, e vedendovi echi immaginativi, forse immaginali, di ciò che so essere stato secoli dopo. Così in qualche modo è Auschwitz il cannibalismo di fine Inferno XXXII–XXXIII, Ugolino, Ruggeri, il mito tebano, la tecnofagia, il «cieco carcere», Lucifero, immensa macchina impersonale, maciulla che trita gli uomini, gli uomini completamente congelati, criogenati nelle acque del Cocito, festuche dentro i blocchi di ghiaccio, totalmente disumani e disumanizzati. Mai Dante, storicamente, avrebbe potuto pensare ad Auschwitz, ma noi, rileggendolo da Auschwitz, qualcosa possiamo intravedervi. L’Inferno è anche una città malata, mortifera, devastata. E Auschwitz la più orrenda e mortuaria delle cittadelle.
Non c’è dubbio allora che può venire un arricchimento reciproco, che pure tenga insieme differenze e somiglianze, rigore, ma anche flessibilità interpretativa. Potremmo allora forse dire che, nell’esempio fin qui adottato, questa ermeneutica ci aiuta a vedere: a) l’irriducibilità di Auschwitz (pur nella mediazione leviana) alla Commedia; pure b): un certo legame che può esistere tra Dante e l’orrore della shoah. Insomma comprendo anche come: c) la nostra lettura della Commedia non sia più la stessa, se assumo anche il punto di vista delle stragi del XX secolo. Questa sensibilità, che non posso non avere come uomo del XXI secolo, mi fa vedere come tanti passi danteschi raccontino una demonica disumanizzazione, che poi so essere avvenuta. Diversissima storicamente, ma affine simbolicamente. Con la Commedia in mano rileggo e giudico Auschwitz. Ma pure, in senso opposto, da quella tragedia, rileggo l’Inferno. L’uno potenzia l’altro, l’uno si distanzia dall’altro. Somiglianze e differenze separano e avvicinano. Non stiamo seguendo il principio di non contraddizione. Qui piuttosto A è sia A che B (e non lo è). La Commedia‑Inferno non è Auschwitz. La Commedia‑Inferno è Auschwitz. E incrociando i mondi, paradossalmente con la Commedia comprendo meglio Auschwitz e con Auschwitz la Commedia. E mi ricordo anche che la Commedia supera e trascende continuamente Auschwitz, con il Purgatorio che è una città‑società in trasformazione, e con il Paradiso che è una città‑società realizzata.
Allo stesso modo, certamente, il regno della lupa denunciato da Dante fin dal I canto dell’Inferno non è in alcun modo il finazcapitalismo odierno, virtuale, transnazionale e speculativo, anche se Dante ‘danna’, tra l’altro, un primo capitalismo commerciale e manifatturiero, una prima finanza e un primo dominio delle banche. Eppure ancora una volta il regno della lupa non è ed è. E dal passato capisco meglio il futuro, come dal futuro capisco meglio il passato e scopro nel mio presente che quella denuncia era vera e lo è più che mai, più di quanto il pur profetico (o presunto tale) Dante potesse immaginare. E scopro ancora che nell’intuizione dantesca c’è un futuro del passato, nel senso duplice che qualcosa balugina, confusamente e inconsciamente (Dante non è Nostradamus), di ciò che sarà, ma, soprattutto, che quel passato ha più futuro del nostro presente. Che in quel passato c’è un futuro perché quell’istanza critica, che pure è stata sconfitta – Dante ha perso, ha vinto la finanza che lui temeva, il capitalismo che non poteva immaginare così predace –, ora è più che mai necessaria e viva. I morti sono vivi, anche. Non solo morti. E i vivi, dimentichi che i confini della vita comprendono anche i morti, sono loro non dei vivi, ma dei non‑morti. Si confronti a proposito di questa condizione il verso dantesco: «Io non mori’ e non rimasi vivo» (If XXXIV, 25). E si legga ‘in sinossi’ con la IV tesi di Berger sui morti:
Considerare i morti gli individui che erano una volta tende a oscurare la loro natura. Provate a considerare i vivi come possiamo presumere lo facciano i morti: collettivamente. Il collettivo si comporrebbe non solo nello spazio, ma anche in tutto il tempo. Includerebbe tutti quelli che hanno mai vissuto. E così penseremmo anche ai morti. I vivi riducono i morti a quelli che han vissuto; mentre invece i morti comprendono già i vivi nel loro grande collettivo.
Lo studioso P. C. Bori, pur partendo da un altro specifico (l’ermeneutica biblica cristiana antica fino ai suoi esiti romantici), ci porta allo stesso doppio dinamismo interpretativo che abbiamo provato a esemplificare e a dire:
Se l’origine illumina la fine, è vero anche il reciproco: il senso dell’ermeneutica sottesa alle metodologie antiche si poté cogliere pienamente solo con il tempo e guardando le cose dal punto di vista del loro esito.
E ancora:
Non è perciò solo vero che a partire dalle antiche formule si possono mettere in luce aspetti nuovi e importanti dell’ermeneutica romantica; è altrettanto vero che a partire dall’esito romantico si possono illuminare, e in un certo senso ‘capire meglio’, gli atteggiamenti antichi.
Del resto opere come la Commedia e la Bibbia vivono continuamente in un tempo esteso, iper‑denso, come ci ricorda Bachtin:
Le [grandi] opere vivono nel ‘tempo grande’. Esse infatti […] non possono vivere nel futuro se non hanno assorbito il passato: l’opera non nasce interamente oggi; se così fosse, non potrebbe neanche vivere nel futuro. È così che […] «possiamo dire che né Shakespeare né i suoi contemporanei conoscevano il ‘grande Shakespeare’ come noi adesso lo conosciamo. Comprimere nell’età elisabettiana il nostro Shakespeare è assolutamente impossibile».
Tanto più questo, ci sembra, vale per la ‘grande Commedia’, come noi già possiamo conoscerla.
Ecco perché anche il paradosso borgesiano del Pierre Menard, autore del «Chisciotte», se inteso in senso simbolico e inter-intratestuale, non è più forse solo tale:
Menard (forse senza volerlo) ha arricchito mediante una tecnica nuova l’arte incerta e rudimentale della lettura: la tecnica dell’anacronismo deliberato e delle attribuzioni erronee. Questa tecnica, di applicazione infinita, ci invita a scorrere l’Odissea come se fosse posteriore all’Eneide […]. Questa tecnica popola di avventure i libri piú calmi. Attribuire a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce l’Imitazione di Cristo, non sarebbe un sufficiente rinnovo di quei tenui consigli spirituali?

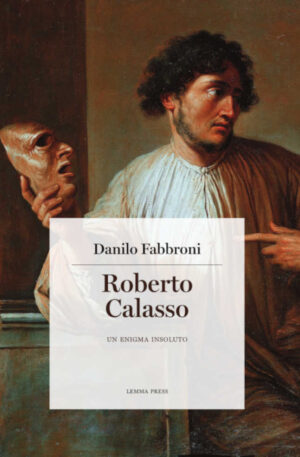



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.