Qui di seguito le prime venti pagine del giallo Il compendio dei morti, di Zoran Živković:
Il basso edificio a un piano era circondato da uno stretto giardino pieno di piante ben curate. Una recinzione di ferro battuto lo separava dalla strada. L’antica costruzione doveva essere stata in origine una villa privata. La sua facciata non lasciava trapelare quale istituzione vi avesse sede. L’allegro mosaico di mattoni gialli e rossi e le alte finestre sarebbero stati più adatti a un servizio dedicato a chi viene al mondo e non a chi lo lascia.
Mentre uscivo dall’auto mi venne in mente che non avevo mai messo piede in quell’edificio, anche se la morte fa parte del mio lavoro di ispettore. Finora non avevo avuto necessità di andarci. Questa volta il motivo c’era, anche se non mi era ben chiaro di cosa si trattasse. Non l’aveva capito neppure il collega Bumbaković che mi aveva chiamato dalla centrale una ventina di minuti prima, proprio quando mi stavo avviando al mio ufficio in questura.
—Dovrebbe andare alla Direzione dei Servizi cimiteriali, via…
—So dov’è, interruppi. Che cosa è successo?
Seguì un attimo di pausa.
—Non so bene. La donna che ha telefonato era agitata e confusa. Parlava di certi libri… che avevano qualcosa che non andava…
Sospirai. Perché i miei colleghi pensano sempre a me appena qualcuno nomina i libri?
—Se è soltanto di un problema di libri che hanno qualcosa che non va, mandate piuttosto la pattuglia più vicina. Che controlli di cosa si tratta esattamente. Sono fuori zona, con questo traffico potrei impiegare anche mezz’ora per arrivare alla Direzione dei Servizi cimiteriali.
Seguì un’altra pausa. Prima di continuare Bumbaković tossicchiò.
—Avrei già mandato una pattuglia, ma quella donna ha chiesto che andasse proprio lei.
—Io? domandai, rallentando un po’. Perché?
—Non ho capito neanche questo. Le faccio sentire la registrazione della chiamata?
—Non occorre. Vado.
Misi il cellulare nella tasca della giacca e premetti sull’acceleratore.
Dovetti spingere bene per aprire il cancello della recinzione in ferro battuto. Il breve vialetto di ghiaia portava a tre larghi gradini davanti all’ingresso dell’ex villa. Il portone era ampio, in armonia con le finestre. Sopra l’angolo superiore sinistro una videocamera non molto grande si mimetizzava in modo camaleontico fra i mattoni gialli.
Afferrai la maniglia, ma qualcuno dall’interno mi precedette. La porta si aprì a metà verso di me, un uomo calvo, piuttosto basso, robusto, con gli occhi acquosi ostruiva il passaggio. Dall’aspetto aveva ampiamente superato i cinquant’anni. La sua uniforme blu di custode era piuttosto sgualcita. Prima che avessi il tempo di presentarmi, cominciò a parlare in fretta sbattendo le palpebre.
—Non ho chiuso occhio per tutta la notte, glielo giuro. Dicono che dormo sul lavoro e che bevo, ma sono solo calunnie. Non è entrato nessuno. Può controllare le registrazioni. Alzò per un attimo la testa verso la videocamera. —È tutta una montatura contro di me, per…
—Rabrenović! lo interruppe dall’interno una brusca voce femminile.
Trasalendo come se fosse stato colto in un’azione inappropriata, il custode spalancò in fretta la porta e s’infilò nella sua guardiola di vetro di fronte all’ingresso.
Il corridoio era largo e ricoperto da una spessa passatoia giallo rossastro. Da sinistra mi venne incontro una donna alta che indossava un tailleur grigio scuro, con una blusa un po’ più chiara. Era più vicina ai cinquant’anni che ai quaranta. I capelli neri di media lunghezza, con le punte piegate verso il mento, incorniciavano un viso allungato e smunto. Grandi occhiali pendevano da una cordicella scura attorno al collo, appoggiati su un seno appena accennato. La donna era quasi senza trucco e calzava scarpe basse.
Si fermò davanti a me e inarcò un po’ le sopracciglia.
—Ispettore Lukić? La voce si era addolcita, ma restava tagliente.
—Dejan Lukić, replicai con un cenno del capo, porgendole la mano.
Prima di stringerla, mi squadrò ancora una volta, come fosse in dubbio; doveva essersi immaginata un ispettore di polizia un po’ diverso. La sua stretta era energica.
—Buongiorno. Hristina Leleković, direttrice dei Servizi cimiteriali. È molto che l’aspettiamo, ispettore. La polizia dovrebbe essere più rapida nei casi eccezionali.
—La polizia è sempre rapida, tranne quando si richiede la presenza di un particolare ispettore. In quel caso è inevitabile che ci voglia più tempo.
—Va bene, lasciamo perdere. Prima di ogni altra cosa sappia che la sua indagine non deve assolutamente turbare la normale attività del nostro servizio. Qualsiasi interruzione o interferenza è fuori questione. La Direzione dei Servizi cimiteriali non smette di funzionare neppure in condizioni di guerra. Ogni altra cosa può essere rimandata, ma non le sepolture. Non c’è niente di più urgente. Spero che sia chiaro.
—Assolutamente. Però non so ancora su cosa dovrei investigare.
—Ma il suo collega non l’ha informata? Gli ho spiegato tutto per bene.
—Da quello che mi ha riferito ho capito solo che è successo qualcosa di strano a certi libri. Vuole spiegare anche a me, per piacere?
Sospirò, scuotendo la testa, poi mi indicò le scale accanto alla guardiola del custode. —Prego, disse avviandosi davanti a me. Pensai che mi portasse di sopra, ma si diresse verso il seminterrato.
Anche il corridoio inferiore era coperto dalla passatoia giallo rossastro, che, forse per l’illuminazione fioca, appariva più lisa. Andammo a destra. Alle pareti fra le porte degli uffici erano appese grandi fotografie in bianco e nero di cimiteri. Le scritte sulle targhette d’ottone poste sul bordo inferiore delle cornici nere erano troppo piccole perché potessi leggerle mentre passavo.
La direttrice si fermò davanti all’ultima porta a sinistra. Prima di bussare gettò uno sguardo sopra la mia spalla, lungo il corridoio. Qualcuno girò immediatamente la chiave e aprì, come se ci avesse aspettato proprio dietro alla porta, .
Un uomo magro di mezza età dal portamento un po’ curvo si fece da parte per lasciarci passare, poi chiuse di nuovo a chiave. Indossava un completo scuro con un panciotto e una cravatta grigia a righe. Aveva la fronte alta, folte basette e occhiali con montatura rotonda di metallo. Senza proferire una parola, si avvicinò alla grande scrivania in mezzo alla stanza e rimase in piedi accanto alla sedia.
Mi guardai attorno. Anche se la stanza non era piccola, sembrava angusta, perché tutte le pareti erano coperte da scaffali chiusi da ante a vetri, pieni di grandi volumi di identica altezza e spessore, il cui colore grigio scuro era quasi uguale a quello del tailleur della direttrice. Percorrendo il vialetto di ghiaia avevo notato le finestre del seminterrato coperte da inferriate lungo tutta la facciata dell’edificio. Qui non si vedevano, quindi erano coperte dagli scaffali: per qualcuno la sistemazione dei libri contava più della luce del giorno. Una plafoniera quadrata forniva l’unica illuminazione della stanza.
Sulla scrivania giaceva un grosso volume aperto e accanto a questo un fascio di documenti. Di fronte al libro si trovava qualcosa che non vedevo da molto tempo: un calamaio. La boccetta stava su un supporto di metallo nero con zampette arcuate, e sorreggeva un portapenne. Dietro all’occorrente per scrivere c’era un vaso rotondo con un fiore giallo.
La direttrice si allontanò un po’ dalla porta, poi fece un gesto vago indicando gli scaffali.
—Questa è forse la stanza più importante della nostra istituzione. L’Archivio. E proprio qui qualcuno ha deciso di danneggiarci.
—Ma l’archiviazione avviene ancora alla vecchia maniera? chiesi. Pensavo che tutti gli uffici fossero stati digitalizzati da tempo.
—Anche questo lo è stato, naturalmente. La modernizzazione non si può evitare, anche se le nostre esperienze in questo campo sono state piuttosto traumatiche. Per due volte addirittura abbiamo quasi perso l’intero database. I computer forse accelerano le pratiche, ma non sono affatto così affidabili come si crede. E si immagina lei la catastrofe se avessimo smarrito i dati che custodiamo?
Mi fissò con aria interrogativa come se si aspettasse una risposta, ma poiché non dissi nulla continuò.
—Da noi si conserva quella che, nella maggioranza dei casi, è l’unica traccia del fatto che una persona sia esistita: i dati su dove e quando è stata seppellita. Tutto il resto è stato dimenticato, si è perso. Come se i morti non fossero neppure vissuti. Non possiamo assolutamente affidare questo prezioso tesoro alla sola conservazione digitale. Per questo, oltre all’archiviazione computerizzata, ci affidiamo a quella tradizionale. Compiliamo i registri delle sepolture, come si faceva fin dai primi tempi. Qui non può succedere che qualcuno, per sbaglio o deliberatamente, prema alcuni tasti e… faccia sparire tutto. Così i morti sono al sicuro.
—Si direbbe però che comunque non lo sono, altrimenti non avreste chiamato la polizia. Che cosa è successo?
La direttrice rivolse un breve sguardo all’impiegato prima di rispondere. La sua voce si fece più bassa.
—È entrato qualcuno stanotte e ha rovistato fra i libri. Ce ne siamo accorti stamattina.
—Rovistato?
—Li ha messi sottosopra. I registri, come vedrà, sono sistemati con ordine. Numerati. Nella prima vetrina – indicò il primo scaffale sulla parete sinistra rispetto alla porta – abbiamo trovato addirittura sette volumi fuori posto.
Mi accostai alla vetrina e la osservai dall’alto in basso. I volumi stavano su cinque file per dodici. L’unica scritta sui larghi dorsi era un numero arabo stampato in oro. In tutte le file i libri risultavano spostati, a prima vista a caso. Cercai di aprire l’anta in vetro, ma era chiusa a chiave.
—Chi ha le chiavi di questa stanza e delle vetrine? chiesi.
—Solo il signor Trpimirović, l’archivista. Indicò brevemente con la testa l’impiegato. —Nessun altro ha accesso qui.
—Ci sono delle chiavi di riserva? Presso il custode, per esempio?
—Non ce ne sono. E se anche ce ne fossero, non sarebbero certamente dal custode. Fece un gesto con la mano senza aggiungere nulla, come fosse tutto chiaro.
—Queste non sono proprio serrature adatte per proteggere oggetti preziosi. Indicai la porta e la prima vetrina. —Qualcuno anche appena un po’ abile le aprirebbe, anche senza chiavi.
—Finora si sono dimostrate del tutto efficaci. Una cosa simile non era mai successa. Almeno non negli ultimi dodici anni e mezzo, da quando sono io la direttrice. Sospirò. —Va bene, le cambieremo. Ne metteremo delle migliori. Non possiamo permettere che ciò accada di nuovo.
—Sarebbe meglio, piuttosto, che modernizzaste questo vecchio archivio. Mettete la videosorveglianza. Le videocamere vi sarebbero più utili qui che all’ingresso. Se le aveste avute, in un attimo avremmo capito chi era il burlone che aveva deciso di scherzare un po’ con voi.
—Un burlone? La sua voce salì di nuovo. —Questo non è affatto uno scherzo. Deve essere considerato nel modo più serio.
—A quanto vedo non è stato arrecato alcun danno. Non è stato rubato o distrutto niente. Sono solo stati spostati dei volumi. Rimetteteli a posto e tutto sarà come prima. La polizia non c’entra nulla.
—Insisto, dovrebbe indagare. È importante stabilire chi ha fatto questo.
Ora fui io a sospirare. Prima mi fa venire qui nel momento peggiore del traffico mattutino, e poi insiste che faccia un’indagine su una ragazzata. Non si tratta così un ispettore di polizia, per quanto importante sembri la faccenda.
Mi avvicinai al tavolo, sollevai un po’ il volume che vi giaceva aperto e guardai il numero sul dorso: 3584.
—Forse i possibili risultati dell’indagine non le piacerebbero.
—Che intende dire?
—Vede, nelle indagini ci affidiamo a una regola che non ha praticamente eccezioni. La soluzione più probabile è quella più semplice. Possiamo anche immaginare che dietro ci sia qualcuno che nel cuore della notte si è introdotto nell’edificio dall’esterno, passando davanti al custode addormentato o nei fumi dell’alcol, rimanendo invisibile per la videosorveglianza esterna; oppure qualcuno all’interno, che sia un esperto scassinatore. Ma perché ricorrere a queste spiegazioni complicate quando ne abbiamo a disposizione una molto più semplice?
—Più semplice? ripetè in tono interrogativo.
—Sì. Esiste una persona per cui è stato facile fare tutto ciò, senza dover entrare furtivamente di notte e senza alcuna effrazione. Qualcuno che senza alcun problema ha potuto aprire sia le porte che la vetrina, perché era l’unico ad averne le chiavi.
Le occorsero alcuni istanti per comprendere di chi parlavo. Aprì la bocca per protestare, ma la prevenni rivolgendomi all’archivista.
—Signor Trpimirović, è stato lei a scoprire che i libri erano stati spostati, non è vero?
—Sì, rispose con voce neutra.
—Come è successo? Cos’è che l’ha indotta a fare attenzione proprio alla prima vetrina? Dentro non c’era il volume su cui lei sta lavorando, che a giudicare dal numero proviene da tutt’altra parte della stanza. Se lei non si fosse fermato davanti alla vetrina e non l’avesse esaminata per bene, non avrebbe affatto potuto notare che i libri erano stati spostati.
Per un momento piombammo nel silenzio. Lo sguardo della direttrice scivolò da me all’archivista. Il viso di lui rimase ines-pressivo. Infine, prima di parlare si schiarì la voce.
—Le chiederei una cosa, ispettore Lukić.
—Come sa il mio nome? La direttrice non mi ha presentato.
—È vero, ma ha insistito che venisse lei. E poiché abbiamo aspettato a lungo l’ispettore richiesto, allora deve essere lei. Che ne pensa, perché la direttrice ha chiamato proprio lei?
Scrollai le spalle. —Non ne ho idea. Ho lasciato questa domanda per ultima. Mi interessa molto sapere perché, fra tutti gli ispettori, ha scelto proprio me.
—Avrà subito una risposta.
Si chinò, aprì un cassetto dalla parte sinistra della scrivania e ne estrasse una grande busta gialla. Conteneva qualcosa di rigido, di forma regolare. Si avvicinò alla prima vetrina. Dalla tasca della giacca tirò fuori un mazzo di piccole chiavi, frugò fra queste, ne scelse una e aprì l’anta di vetro. Pose la busta in piedi davanti ai libri della fila centrale, poi chiuse la vetrina senza usare la chiave lasciata nella serratura.
—L’ho trovata così quando sono arrivato alle otto. È abbastanza vistosa da attirare la sua attenzione?
Il rettangolo giallo in effetti risaltava parecchio sullo sfondo grigio scuro. Non si poteva non notarlo, anche posandovi lo sguardo per un istante.
—Cos’è? chiesi, comprendendo nello stesso istante di aver fatto una domanda stupida.
Un sorriso sfiorò le labbra dell’archivista.
—Una busta. Era una risposta letterale, proprio come la mia domanda meritava. Riaprì la vetrina e la tirò fuori. Poi richiuse a chiave l’anta e mise in tasca il mazzo di chiavi. Mi si avvicinò e mi porse la busta. —È indirizzata a lei. Ecco perché l’abbiamo chiamata.
Ebbi un attimo di esitazione prima di accettarla. La girai sul davanti e mi balzarono agli occhi quattro parole scritte al centro con una penna rossa: Per l’ispettore Dejan Lukić. La grafia mi era ignota.
Passai con lo sguardo dalla direttrice all’archivista. Poi aprii lentamente i due fermacampioni in cima, separai i lembi della busta e diedi un’occhiata all’interno.



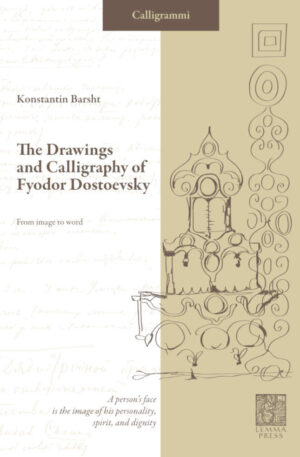

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.