Qui di seguito le prime diciotto pagine de Il primo libro del mondo. Alle origini del poema dantesco, di Sergio Pasqualini:
INTRODUZIONE
Che la Divina Commedia sia il primo libro del mondo, di tutti i tempi e di tutte le letterature, è un’affermazione così assoluta e perentoria che può sembrare esagerata. Eppure, attraverso i secoli, si rincorrono innumerevoli giudizi di grandissimi poeti e scrittori che possono avvalorarla. A partire dall’inglese Geoffrey Chaucer che, nei Racconti di Canterbury, composti a fine Trecento — e precisamente nel Racconto del Monaco, dove narra la tragedia del conte Ugolino — fa sì che il novellatore di turno inviti i suoi uditori a leggersi «il grande poeta italiano, chiamato Dante, che sa dir tutto punto per punto, senza una parola fuori posto». Chaucer fu il primo a impiegare il volgare — il cosiddetto middle English — in un’epoca in cui i poeti d’Oltremanica adoperavano soltanto il latino o il francese; e questa decisione coraggiosa, che lo rese il capostipite della letteratura del suo paese, la derivò proprio dall’esempio della Commedia, dalla quale era rimasto folgorato durante uno dei suoi viaggi in Italia.
Attestati di supremazia vengono poi da Giovanni Boccaccio, Ludovico Ariosto, Galileo Galilei, John Milton, Giambattista Vico, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Lord Byron, William Blake, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, Eugenio Montale, Ezra Pound, Thomas S. Eliot.
Ma le menzioni più ricorrenti sono da attribuire al grande scrittore argentino Jorge Luìs Borges, la cui autorictas è sublimata, non ridimensionata, dal fatto che non vinse il Premio Nobel, circostanza che lo apparenta agli altri due massimi scrittori del Novecento, Marcel Proust e James Joyce, collocandolo molto sopra la stratosfera degli ordinari premi Nobel per la Letteratura, fra i tre astri allineati nella Cintura di Orione, sul cielo stellato della prosa e della poesia dove brillano, più in alto, i giganti della letteratura di tutti i tempi.
Sono molti i richiami di Borges in merito alla preminenza del poema sacro. Si possono reperire in scritti, conferenze, interviste: dai Nove saggi danteschi alle Sette conversazioni con Fernando Sorrentino, e in altre due interviste concesse a Osvaldo Ferrari e Fabio delle Seta, al quale dichiara che gli sembra «quasi una bestemmia comparare Dante con qualsiasi altro poeta, perché è molto al di sopra di tutti gli altri». La Commedia — afferma in uno dei Nove Saggi — è «il miglior libro scritto dagli uomini […] l’apice della letteratura e delle letterature […] un libro infinito», dove «non c’è parola che sia ingiustificata». Postilla, quest’ultima, quanto mai significativa, giacché nelle opere in versi, per rispettare la metrica e la rima, l’autore è spesso costretto a interpolare nel testo particelle, termini ridondanti, riempitivi gratuiti dal punto di vista testuale, obbligati però dalle regole della prosodia, dalla cadenza degli accenti nel verso — a sua volta condizionato da quello che lo precede e vincolante l’altro che lo segue. La Divina Commedia, invece, esibisce un testo netto, pulito, impeccabile, senza ripieghi o gratuità, compilato tenendo fra loro stretti e allineati la forma e il contenuto, in una piena convergenza di movimento lirico e sviluppo narrativo. Ciascuna parola s’incastra tra le altre alla perfezione, come in un puzzle privo di tessere posticce, ritagliate all’occasione per essere intercalate in modo da assecondare le occorrenze ritmiche del dettato.
Borges non conosceva la nostra lingua; aveva letto, compreso e memorizzato il testo originale della Commedia facendosi aiutare da una traduzione inglese a fronte. «Non conosco l’italiano», affermò. «Conosco solo l’italiano di Dante». Come dire che la lingua di Dante basterebbe da sola a rappresentare l’idioma dell’intera Nazione.
Da parte sua, il grande poeta anglo-statunitense Thomas S. Eliot affermava: «Dante e Shakespeare si sono divisi il mondo a metà. Non è rimasto spazio per un terzo». Ma altrove riconosce che, tra i due, Dante è certamente il più universale e completo, giacché non si limitò a scandagliare gli abissi e i tormenti dell’animo umano, non si limitò a rappresentare passioni e desideri terreni (leggi: inferno e purgatorio), ma esplorò pure l’ineffabile, rappresentò il paradiso, e lo fece dall’interno, entrandovi dentro. Una cosa, questa, preclusa all’immaginario moderno, confinato nel recinto della contingenza. Lo stesso si può dire di Ezra Pound (i cui Cantos traggono il titolo proprio dai canti della Commedia, e il cui amore per Dante fu tale da indurlo a comporne due in lingua italiana), giacché anch’egli, nell’opera plurale fatta di centoventi Cantos, si limitò a visitare gli inferni e i purgatori del Novecento, con l’aspirazione di elevarsi alla «Luce» si riprometteva, ma senza realizzare in effetti una rappresentazione fattuale o sia pure allusiva del terzo Regno.
Anche James Joyce considerava il poema sacro uno dei libri più belli che fossero stati mai scritti. «Amo Dante» disse «quasi quanto la Bibbia. È il mio cibo spirituale, il resto è riempitivo». La più grande poetessa russa del Novecento, Anna Achmatova, aveva imparato l’italiano al solo scopo di leggere la Divina Commedia. «Lei ha mai letto Dante?» le fu chiesto. «Io non faccio altro che leggere Dante» aveva risposto. Pure l’altro grande poeta russo, suo amico, Osip Mandel’štam, aveva studiato la nostra lingua per poter leggere nell’originale il poema, sedotto dalle forti impressioni in lui suscitate dalla traduzione russa. Certo, è rimarchevole che una semplice traduzione possa indurre al faticoso studio preliminare di un idioma straniero al solo fine di ascoltare alla fonte la viva voce dell’autore. Osip Mandel’štam fu vittima nel 1938 delle purghe staliniane, e condivide il tragico destino con Pavel Florenskij, geniale e poliedrico matematico e filosofo della scienza, che era stato fucilato l’anno precedente. Anch’egli va annoverato tra i cultori di Dante, e fu tra i primi a ravvisare nella cosmologia della Divina Commedia l’intuizione di concetti spaziali che anticipano le geometrie non-euclidee, e un modello di spazio ellittico chiuso in sé stesso, unilatero come il nastro di Möbius, che prelude all’universo finito e illimitato di Einstein.
La Commedia ha dunque la virtù singolarissima di far crescere su di sé e da sé un discorso infinito, ovvero un’infinità di discorsi, di coinvolgere sterminate schiere di lettori in un colloquio corale che dura da secoli. Critici di professione, cultori appassionati, comuni lettori, tutti si sentono come attratti da un magnete potentissimo e, una volta che sono stati catturati dal suo campo, non pensano più a evaderne. Il poema dantesco è un organismo vivo in sé compiuto, che cresce e germoglia compatto, normato e regolato; con talune eccezioni, sì, ma necessarie, come su questa Terra delle eccezioni sono sempre necessarie alla regola. Dio si manifestò per amore componendo il Libro del creato, e per amore si rivelò agli uomini dettando il testo della Bibbia. La Divina Commedia è quell’Opera-Mondo che vuol porsi come specchio che riflette entrambi i Libri, rivestendo di episodi e figure visibili i segni e i simboli in essi racchiusi.
A questo punto, visto che pareri tanto insigni e frequenti collocano Dante in solitaria posizione di vertice, si può azzardare una metafora o, più esattamente, una serie di metafore, e affermare che una lirica isolata — un sonetto di Petrarca, ad esempio — è un limpido, scintillante, sonoro ruscello; l’intera raccolta del Canzoniere assomiglia a una lunga vallata disseminata di sorgenti, fontanili, laghi di cristallo; un poema epico di contrasti e peripezie, come l’Odissea, fa pensare a un corso d’acqua con repentine cascate, tratti di rapide, confluenza di torrenti; un romanzo, tipo la Recherche proustiana, a un fiume interminabile che procede lento, tutto anse e meandri. Ebbene, comparata a questi esempi, la Commedia dantesca appare come un fiume maestoso che spacca in due un continente e sfocia nell’oceano con un estuario immenso.
1. Il significato del termine ‘Com(m)edia’
Nell’Epistola XIII, quella in cui dedica la «cantica sublime», il Paradiso, a Cangrande della Scala, l’autore definisce l’accezione tecnica e retorica di quella ‘comicità’, che considera la caratteristica saliente dell’opera, e la individua nei seguenti tre aspetti.
In primo luogo, il sacrato poema è comedia in quanto adopera il volgare. Non il volgare illustre e sorvegliato perseguito nel De vulgari eloquentia, bensì il volgare più diffuso e comune, che può essere inteso a orecchio da chiunque, comprese le muliercule, le donnette. Cioè, un parlato umile e dimesso (remisse et humiliter), che tuttavia, in certe parti, può attingere livelli alti e sublimi (elate et sublime). A Dante preme insomma una comprensione facile e piana del testo, ai fini di una diffusione popolare del poema il più ampia possibile. Vuole che chiunque lo possa intendere per il mezzo della parlata comune a tutti, in quanto a tutti deve recare il beneficio di quella redenzione che coincide con la piena felicità del corpo e dell’anima. Il fine principale della Commedia è infatti — lo dice espressamente — etico, deve cioè riuscire di profitto alla vita virtuosa di tutti quanti gli uomini, in modo che possano condurre un’esistenza conforme alla volontà divina e guadagnare la vita eterna. Il termine greco comos, dal quale fa derivare quello di comedia, significa ‘canto di villaggio’, vale a dire, appunto, racconto in versi popolaresco, a tutti comprensibile. Si tratta di una concezione consapevole, profondamente radicata, tanto che nella II Egloga all’amico Giovanni del Virgilio, che gli chiedeva di confezionare carmi in lingua latina, replica di sentirsi più che soddisfatto dei «comica verba» impiegati nella Commedia. Dall’avere adoperato il volgare, dice altrove, ha tratto così tanta gloria che, per essa, è disposto a buttarsi alle spalle persino le amarezze dell’esilio: «huius dulcedine glorie nostrum exilium postergamus».
Se consideriamo che la lingua del sacro, di tutte le opere connotate dal divino, era quella latina, fu una scelta davvero coraggiosa e inedita adoperare il volgare delle muliercule.
In secondo luogo — al fine di comprendere appieno il significato che Dante aveva di comedia, ovverosia di ‘comico’ — è necessario premettere che nel Medioevo tragico e comico non erano intesi come nell’età classica greco-romana, non erano più intesi in relazione a tragedia e commedia, cioè a opere di recitazione da parte di attori agenti sul proscenio d’un teatro a beneficio di un pubblico che fruiva dei loro dialoghi e delle loro gesta. Tragico e comico venivano intesi, piuttosto, come registri stilistici: il primo, alto e solenne; il secondo, umile e basso. Sebbene Dante introduca una correzione, consentendo alla sua comedia la possibilità d’impennarsi a vette sublimi. Insomma, ha del ‘comico’ un senso estensivo, in quanto può includere, accanto allo stile remisse et humiliter, pure lo stile elate et sublime dell’epica. E questa doppia modalità la praticò in tutte e tre le cantiche; così che nell’Inferno possiamo trovare i versi di registro alto di Francesca e di Ulisse, oppure tragico, come nell’episodio del conte Ugolino; mentre, nel Paradiso, sentiremo tuonare le imprecazioni triviali di San Pietro nei confronti dei papi che usurpano il suo soglio, trasformandolo in «cloaca del sangue e della puzza».
Per questa commistione di umile e sublime, possiamo considerare Dante il primo che rompe con la tradizionale dicotomia aristotelica che vuole distinte le categorie del comico e del tragico, il capofila di quella tendenza al dramma moderno che le contamina, con l’intento di rappresentare la vita umana nel suo reale impasto misto e mutevole.
Infine, un terzo aspetto di ‘comicità’, secondo Dante, consiste nel modo in cui procede l’intero cammino del racconto che, da un principio horribilis et fetidus — l’Inferno — vede nell’ultima cantica — il Paradiso — una prospera, desiderabilis et grata conclusione.
Con ciò, ho definito il punto di partenza del saggio, richiamando i moduli della poetica medievale, così come sono enunciati, e insieme ritoccati, dalla formulazione dell’autore. Ma questa è solo una definizione storica, riferibile ai tempi e alla concezione di Dante, non ha ancora attinto una dimensione critica compiuta, adeguata a quelli che sono diventati gli apparati interpretativi della narratologia moderna. La Commedia è opera di tutti i tempi e, come ogni epoca ha trovato del nuovo nella compagine dell’opera, così è lecito riesaminare in modo aggiornato — pur senza abbandonare le pregiudiziali che pone Dante e cadere nel fraintendimento — il significato del termine ‘comedia’ che etichetta il poema: il sacrato poema. Il quale è tutto sacrato, compresi Inferno e Purgatorio; così com’è tutto ‘comico’, pure il Paradiso.
D’ora innanzi parlerò di Comedia, con una ‘m’ sola, perché così fa Dante, e continua a farlo Boccaccio nel Trattatello in lode. Parlare di Commedia, con due ‘m’, ai fini di questo saggio può risultare al principio fuorviante in quanto, risuonando dell’accezione moderna, sembra alludere a qualcosa di teatrale, di sceneggiato, di finto, mentre il poema ha solide fondamenta d’autenticità e un intento etico serio e determinato. Ci porterebbe, inoltre, lontani dalla vera e complessa natura del termine Comedia che, dice l’autore, non è depositaria di un significato univoco, bensì è polysemos, in quanto accoglie insieme i quattro sensi scritturali — letterale, allegorico, morale, anagogico —, e pertanto diventa un genere polimorfo e fuori schema. In particolare, va posta in rilievo la natura duplice del testo, in quanto esso procede simultaneamente su due livelli, e a quello superiore dell’evidenza narrativa associa una sottotraccia allegorica o morale che, come un fiume carsico, talora affiora in superficie, talora s’inabissa sotto il «velame de li versi strani». Per ciò, si può dire che Dante abbia portato avanti in simultanea un poema doppio, trascritto uno spartito su due tracciati: le voci del coro sopra, le note d’orchestra sotto.
Partiamo dalla segnalazione di un fatto, tanto evidente e macroscopico che si finisce quasi col non notarlo. Comedia, ovvero Divina Comedia, non è il titolo dell’opera. Comedia non è un titolo, alla stregua di Iliade, Odissea, I promessi sposi, Guerra e pace, Moby Dick. È una denominazione che sovrasta qualsivoglia titolo in genere si premette a un’opera a compendio del tema principale che tratta. Comedia indica il genere formale («Comedia est genus», dice Dante) o, meglio, l’amalgama dei registri stilistici che riverbera quest’opera, tanto immane da non poter essere definita e circoscritta da un semplice titolo di sintesi denotativa. La Comedia non è semplicemente una storia, una fabula, vale a dire il racconto di una serie di vicende terrene quali quelle di Ulisse, quelle di Renzo e Lucia, quelle della caccia alla balena bianca, una sequenza di episodi particolari scorciata in un titolo netto e stringato come Odissea, I promessi sposi, Moby Dick. È piuttosto uno scrigno di storie, tante storie, tutte diverse, tutte esemplari, non particolari. E non si tratta di storie staccate come nel Decameron, bensì congiunte in un flusso ininterrotto, scandito in tre sequenze, le Cantiche, ma sempre connesse dallo stesso filo conduttore. Né si obbietti, a questo punto, che anche il Decameron possa indicare un genere speciale alla stregua di Comedia, dato che quel titolo si riferisce a una caratteristica puramente numerale, cioè al fatto che le cento novelle sono ripartite in dieci giornate. Rimanda a una schematizzazione del tutto relativa (che infatti, mutuata dall’Exameron di Sant’Ambrogio, avrà ricalco in raccolte analoghe, quali l’Heptaméron di Margherita d’Angoulême o il Pentamerone di Giambattista Basile); e dunque non sovrasta solitaria all’opera definendone l’intrinseca natura — il genere, assoluto e unico al mondo —, ma si limita a indicare la suddivisione dei racconti in giornate.
I titoli veri e propri del poema sono se mai piuttosto quelli delle Cantiche: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Un’opera con tre titoli. Tre, perché tutta la struttura dell’opera è triadica, dalle ripartizioni più ampie in Cantiche e Canti, alla compitazione delle singole strofe con le tre rime che le incatenano, sino ai particolari più fini e sottili del tessuto narrativo. E di queste tripartizioni — che potremmo definire telescopiche, in quanto s’innestano e insieme slittano le une sulle altre, e dalla massima ampiezza vanno a convergere nei particolari strutturali più minuti — la più distintiva viene dal fatto che l’autore ha creato ex novo, inventato di sana pianta, l’incedere strofico delle terzine incatenate: incatenate cioè da tre rime che annodano le strofe l’una all’altra, con la disinvolta chiusura dell’ultimo distico spezzato del canto, a interromperne la sequenza altrimenti di per sé senza fine. Davvero un caso singolare, unico in tutte le letterature del mondo, quello in cui l’autore non si è limitato a redigere il contenuto, la sequenza delle vicissitudini narrate, ma ne ha apprestato il contenitore, regolamentato l’intera struttura inedita del poema e plasmato il plesso metrico dove riversarle; non si è limitato a orchestrare il racconto, ma ne ha ordito l’assetto distributivo generale e, insieme, approntato la trama formale per declinarlo in sequenza di terzine legate — quelle che lui chiama ‘rime’ [rithimos].
Un’opera, si diceva, con tre titoli. Ma il libro nel suo complesso, la Comedia, li sovrasta, sovrasta questi tre titoli; è una definizione che allude alla polivalenza del genere letterario impegnato. È un po’ come se un narratore, ai nostri giorni, avesse composto un romanzo capitale, e questo romanzo fosse così molteplice nelle forme e universale nei contenuti da non poter essere risolto in titolo. Il nostro narratore non avrebbe scritto un romanzo, bensì il ‘Romanzo’, al quale i posteri poi, ammirati e soggiogati, assegneranno l’attributo esponenziale di «divino»: il «Divino Romanzo»!
E non basta. Per intendere pienamente il senso del termine, occorre puntualizzare che Comedia non indica propriamente un genere preciso (come nel caso del ‘romanzo’ evocato in metafora), quanto intende, piuttosto, richiamare l’intera collezione dei registri letterari mobilitati nel poema, impegna cioè uno spettro ben più vasto e vario di quello ingaggiato da un singolo genere letterario.
Nell’Epistola XIII, al capo 29, è detto espressamente: «Est comedia genus quoddam poetice narrationis ab omnibus aliis differens» (La comedia è un genere di narrazione poetica differente da tutti gli altri). Il termine ‘comedia’, in effetti, non ha precedenti, lo ha coniato Dante. Si tratta di una intestazione iniziale che sovrasta, dicevamo, i titoli delle singole cantiche. È dunque evidente che l’autore ha inteso conferire al termine il senso di ‘genere’ inedito, ab omnibus aliis differens, appunto. Era consapevole che questa sua opera, mista di umile e sublime, non solo costituiva un prototipo assoluto, senza precedenti e senza presumibile seguito, nella storia universale della poesia, ma aveva un imprinting trascendente, soprannaturale: «divino», come lo apostrofarono i posteri. È pertanto necessario denotare in modo più complesso il multiverso formale di quest’Opera-Mondo che il Poeta chiama «Comedia». Ci troviamo di fronte a un genere di testo assolutamente unico, un testo polimorfo che accoglie, misti o avvicendati, svolgimenti stilistici diversi. Vi ritroviamo il registro comico (nel senso corrente del termine), quello ironico, il grottesco, l’elegiaco, il lirico, l’idillio bucolico, il patetico, l’epico, il tragico, il drammatico, il noir, l’horror; il contrasto, la forma dell’invettiva, quella della liturgia. E l’agiografia, la profezia, l’autobiografia, la mitopoiesi, la poesia civile e didascalica, la notazione astronomica, quelle cosmologica, geografica, geologica, e, sparse per tutto, le catalogazioni etiche e le enunciazioni teologiche.
A mo’ di esempio, ecco alcuni casi particolari di questa polimorfia di registri espressivi.
Un’ordinaria comicità sfrigola dagli sberleffi e dagli scorni dei diavoli nella bolgia dei barattieri. L’ironia screzia la battuta finale dell’ipocrita che, maliziosamente, fa intendere a Virgilio che i diavoli l’hanno gabbato; e, sempre dell’ironia, trapunta il sottinteso scherzoso delle facezie che Dante e Belacqua si scambiano sulla pendice dell’Antipurgatorio. Il grottesco snatura l’aspetto e gli astrusi sproloqui di Pluto e Nembrot. L’andante elegiaco palpita all’esordio del canto viii di Purgatorio: «Era già l’ora che volge ‘l disio / ai navicanti e intenerisce ‘l core…» L’afflato lirico si leva, purissimo, nella celebre terzina: «Quale nei pleniluni sereni / Trivia ride fra le ninfe etterne / che dipingon lo ciel per tutti i seni». L’idillio bucolico fiorisce sui giardini dell’Eden all’apparire di Matelda, che canta cogliendo fior da fiore, e al poeta rammenta Proserpina, quando spiccava narcisi sul prato, e all’improvviso il terreno si squarcia, balza fuori Ade, il dio degli Inferi, a rapirla: sì che «perdette la madre lei ed ella primavera». Una corda patetica vibra negli episodi di Paolo e Francesca, di Cavalcante de’ Cavalcanti, mentre l’empito epico s’innalza nell’episodio del folle volo di Ulisse; s’impenna nella rievocazione dell’Aquila imperiale della Provvidenza che governa la storia di Roma, intonata da Giustiniano nel vi di Paradiso, specialmente nelle trascinanti terzine che evocano le fulminee imprese di Cesare. Il tono drammatico impronta di sé il recriminatorio racconto di Guido da Montefeltro e quello, speculare e contrario, ma sedato, del figlio Bonconte. L’assassinio di Jacopo dal Cassero — che vede «de le sue vene farsi in terra laco» — introduce un fotogramma noir, che fa pensare a scene di film dove la pozza del sangue della vittima si spande scura sul pavimento. Il tragico irrompe nell’atroce, funesta, carnivora vicenda del Conte Ugolino, il cui morso canino sul cranio dell’arcivescovo traditore trasforma all’istante il timbro tragico nel tono sdegnato dell’invettiva: «Ahi Pisa, vituperio delle genti…» La Comedia è disseminata d’invettive. Nell’Inferno troviamo quella, sarcastica, del «Godi Fiorenza poi che sei sì grande…»; in Purgatorio quella, lamentevole all’esordio, poi sempre più acre, che principia dall’«Ahi serva Italia di dolore ostello…»; in Paradiso, la più feroce di tutte, quella in cui san Pietro si scaglia contro chi usurpa e contamina il luogo della sua sepoltura. Il modulo dell’invettiva è quello dove l’intonazione civile — che pervade l’intero poema manifestandosi in varietà di forme — assume gli accenti più crudi e risentiti.
L’horror è spesso evocato dai mostri infernali, e il granguignolesco più truculento contamina la bolgia dei seminatori di discordia, ove Maometto, squartato «dal mento infin dove si trulla» — fino all’ano, dove si scoreggia — incede con le budella che gli penzolano fra le gambe, la corata e il tristo sacco dello stomaco — che trasforma «in merda quel che si trangugia» — esposti alla vista. Avanza orrendo, suggerendo a un tempo il senso del fetore che emana. C’è poi il rimpallo del contrasto (o rinfaccio) nell’alterco tra il greco Sinone — quegli che, istruito da Ulisse, mentì ai Troiani propiziando l’ingresso nella città del cavallo di legno — e il monetier Maestro Adamo, con lui dannato nell’ultima delle dieci bolge per aver falsificato la lega dei fiorini d’oro suggellata del Batista.
Voltando di centottanta gradi, passiamo a brani del modulo liturgico, quello che mima lo stilema della preghiera. Lo ritroviamo nella parafrasi del Padrenostro, all’inizio dell’XI canto di Purgatorio: «O Padre nostro che ne’ cieli stai…»; rispunta nell’invocazione di san Bernardo alla Madonna, nell’ultimo canto del Paradiso: «Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura…» Mentre vento di profezia spira nelle terzine del Veltro e in quelle dove Beatrice annuncia il prossimo avvento del «Cinquecento diece e cinque».
La Comedia accoglie diversi riferimenti autobiografici. La «cara e buona immagine paterna» di Brunetto Latini; la corda che Dante si sfila dalla cintola, e Virgilio getta giù nell’alto burrato a richiamarne Gerione — corda con la quale, a suo tempo, aveva pensato di pigliare la bestia a la pelle dipinta; il pozzetto battesimale che aveva ordinato di rompere per salvare un bimbo che vi era scivolato dentro e stava annegando; la paura dei «fanti ch’uscivan patteggiati di Caprona» a veder «sé tra nemici cotanti»; i trascorsi giovanili con l’amico Forese; le trasgressioni che gli vengono rimproverate da Beatrice sul Paradiso terrestre; le amarezze dell’esilio profetizzate dall’avo Cacciaguida nel cielo di Marte.
Seguono l’agiografica rievocazione delle vite di san Francesco e san Domenico, nei canti XI e XII del Paradiso, la poesia didascalica con cui Stazio illustra la fecondazione e l’evoluzione del feto. Anche la disquisizione mediante la quale Beatrice, provando e riprovando, confuta le opinioni di Dante ed espone la vera natura delle macchie lunari, rimanda al genere della poesia dottrinale. Un racconto mitopoietico è poi quello del Veglio di Creta. Anche l’episodio di Ulisse propone, riformulando il narrato omerico, il mito moderno dell’insopprimibile brama di conoscenza da parte dell’uomo. Abbiamo i versi, di puntigliosa precisione descrittiva e sontuoso compendio lirico, che illustrano sistemi astronomici e cosmologici, richiamano eventi meteorologici e sismici, rievocano episodi della storia o forniscono dettagliati ragguagli geografici. Come quando, nel canto xx dell’Inferno, Virgilio indugia nella descrizione — lunga la bellezza di una ventina di versi — della regione che dal Benaco (lago di Garda), attraverso Peschiera, il corso del Mincio, arriva fino alle acque stagnanti che contornano Mantova (nei pressi della quale lui, Virgilio, era nato) rendendola inespugnabile; e nel farlo l’antico poeta elenca con precisa dislocazione territoriale, quasi stesse enumerando a volo d’uccello i punti salienti di un paesaggio, diversi toponimi di monti, fiumi, borghi, castelli del luogo. La rassegna dei vari registri stilistici impegnati nella Comedia termina segnalando le ripartizioni etiche (nei canti in cui Virgilio chiarisce a Dante l’ordinamento morale dell’inferno e del purgatorio) e le digressioni teologiche sparse un po’ per tutto il poema, segnatamente nella terza cantica. La silloge dei canoni stilistici e tematici profusi nella Comedia sorpassa di gran lunga il numero di quelli che si ritrovano nei libri della Bibbia, come pure la varietà di moduli formali ingaggiati in distinti capitoli dell’Ulisse di Joyce. È così che va intesa la plurima e frammista ‘comicità’ del poema. Possiamo dire che quasi tutte le modalità in cui si possa manifestare l’espressione letteraria vengano impiegate, alternate o rifuse, nel corso dell’opera, avvicendate nel corpo del singolo canto secondo le occorrenze del testo. Il che rende più appropriato e conveniente il termine comedia, con una m sola, a contrassegnare l’unicità genetica del poema, di un’opera assolutamente atipica, che include quasi tutte le configurazioni fruibili in ambito letterario. Compresa una che non esisteva ai tempi di Dante, che esiste oggi. Pensateci un attimo. Il poema dantesco non presenta forse un impianto cosmologico e scenari più che terrestri? Il protagonista discende i gironi dell’inferno sino al centro della Terra; quindi, risale un cunicolo e rispunta agli antipodi, a riveder le stelle; scala il monte più alto del mondo, il purgatorio e, giunto al Paradiso terrestre, a fianco di Beatrice attraversa la sfera dell’aria — evento talmente inaudito che al principio neppure lui si rende conto che sta volando, fin quando gli viene fatto notare dalla Donna celeste. Passata la sfera del fuoco, approda al cielo della Luna; addirittura penetra nella materia nebulosa, eppure trasparente, tersa, eppure solida, della prima stella. E anche qui non si capacita di come abbia fatto la fisicità del suo corpo a compenetrare la materia di un altro corpo. Attraversa poi, l’una dopo l’altra, le successive otto sfere cristalline fino all’ultima, il velocissimo Primo Mobile («commutatore dell’eternità in tempo», scrive Vittorio Sermonti: trasduttore dell’immobilità perenne dell’Eterno nel tempo entro cui ruotano i cieli sottostanti), per immergersi infine nell’Empireo, la Mente di Dio. Non si tratta forse del primo viaggio abissale, e poi interstellare, compiuto da un uomo — «astronauta mistico», come lo chiama più volte lo stesso Sermonti nel commento del Paradiso — sino al centro della Terra, quindi verso le stelle e oltre le stelle? Un viaggio ultraterreno! E, ultraterreno, non può considerarsi lontano sinonimo di extraterrestre? O, per dire meglio, ‘extraterrestre’ non è ricalco esobiologico odierno del termine ‘ultraterreno’ usato in ambito religioso? Il poema non ha insomma — più curato e potente, variegato e all’interno coeso — un impianto generale che sa di fantascienza? Sembra quasi che la Comedia preannunci molti dei moduli tematici elaborati da romanzieri e sceneggiatori di adesso. Col distinguo, però, che la fantascienza, così com’è praticata oggi, è un termine che gli va stretto, molto stretto. Quando parliamo di fantascienza, pensiamo a un genere avventuroso e fantastico di puro intrattenimento, non certo a un impianto complesso e convincente, moralmente orientato, come quello che apparecchia Dante. Nella fantascienza odierna, fantasia e scienza si mescolano, si fondono, — come nello stesso sostantivo composto ‘fanta/scienza’ —, e ciascuna contamina l’altra, dando vita a un pastiche gratuito e aleatorio. Mentre nella Divina Comedia fantasia e scienza non si mischiano, permangono distinte, ciascuna a presidiare la propria sfera di competenza, come si vedrà nel prossimo capitolo.




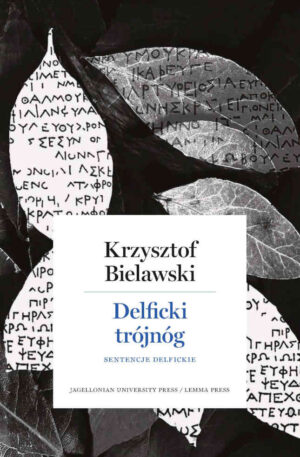
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.